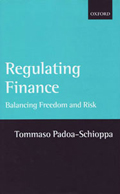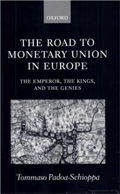L’alternanza e la continuità
I cambi di governo nella democrazia italiana.
Nel 1994 l’ Italia compì un passaggio che è momento classico della maturazione di ogni democrazia: dal governo di una sola parte all’ alternanza nel governo. Per arrivarci ci vollero quasi 50 anni di libertà politica, il cambiamento della legge elettorale imposto dagli elettori ai partiti, la caduta del comunismo, il rientro dell’ estrema destra nell’ arena politica. Nella Spagna postfranchista bastarono meno di 5 anni per compierlo, in Germania ce ne vollero circa 20, nella Francia della quinta repubblica 23, in Corea oltre 40, in India oltre 50, in Messico oltre 70. In Giappone il momento non è ancora avvenuto.
Quel passaggio ha portato al nostro sistema politico grandi benefici, ma anche esigenze e rischi nuovi. Tra questi la necessità di trovare un punto di equilibrio tra continuità e discontinuità, tra contrapposizione e larghe intese, tra politiche partisan e bipartisan, come si dice in America.
Nei giorni passati su queste colonne prima il Direttore si è pronunciato fortemente contro una grande coalizione in Italia (Corriere, 8 novembre), poi Sergio Romano ha messo in guardia contro il pericolo che l’ opposizione, se diventerà maggioranza, si dedichi soprattutto a cancellare l’ opera del governo precedente (Corriere, 11 novembre). A qualche lettore può essere sembrato di ricevere due inviti contraddittori, uno alla contrapposizione, l’ altro alla concordia. Invece i due inviti sono coerenti, anzi complementari. Semplicemente, essi rivelano la complessità della politica in una democrazia dell’ alternanza.
Paolo Mieli ha sottolineato il rischio dell’ eccesso di continuità e di opacità che corre un sistema politico senza alternanza. Sergio Romano ha sottolineato il rischio dell’ eccesso di discontinuità e di disordine che corre un sistema con alternanza. Dal 1994 la giovane democrazia italiana, tuttora in fase di apprendistato, cerca un equilibrio tra i due rischi.
Alla radice vi è una questione capitale, forse addirittura la questione essenziale del sano funzionamento di una comunità politica: in che cosa dividersi e in che cosa concordare perché la repubblica sia ben governata?
Una prima risposta è: si concordi sulla Costituzione, ci si divida sulle politiche ordinarie. Da una parte, attribuzione e limiti del potere (prerogative di governo e parlamento, diritti della minoranza parlamentare, libertà politiche e civili, diritti di proprietà, controllo delle forze armate, e via dicendo); dall’ altra, uso concreto del potere (istruzione, tutela del lavoro, regime pensionistico, politica estera, e altro ancora). La risposta è corretta, ma a ben vedere è anche imprecisa e insufficiente. Corretta, perché – quasi per definizione – la linea che separa la Costituzione dalle politiche ordinarie riflette il patto in base al quale la minoranza accetta di essere governata dalla maggioranza. E tuttavia imprecisa, perché la Costituzione stessa può essere modificata anche senza accordo unanime, ed è giusto che possa esserlo. Una Costituzione immutabile è condannata a perire. La risposta è anche insufficiente, perché la contrapposizione totale tra forze politiche in ogni materia non costituzionale è impossibile e sarebbe addirittura rovinosa.
Potrebbe un nuovo governo costruire una seconda autostrada Milano-Roma per darle il percorso che il governo precedente aveva scartato?
E quale sarà il punto di non ritorno per il ponte sullo stretto di Messina? E l’ euro, è di Prodi o dell’ Italia? E le carriere dei magistrati: è concepibile che siano separate e ricongiunte a ogni volgere di maggioranze? La scelta tra continuità e cambiamento non appartiene solo alla Costituzione; in gran parte appartiene alla politica ordinaria. E la qualità di tale scelta è parte essenziale del buongoverno.
Converrebbe che gli avversari si mettessero d’ accordo su ogni grande decisione o che addirittura governassero insieme? Non credo. La concorrenza è essenziale per il buon funzionamento della politica come per quello dell’ economia. Il rischio di perdere il potere è, e deve rimanere, stimolo a ben governare. La lontananza dal governo è condizione indispensabile per correggere errori, elaborare nuovi programmi, individuare volti e talenti nuovi per la politica. Neppure è vero che le intese e le maggioranze debbano essere tanto più ampie quanto più importante è la questione trattata: di fronte a una scelta qualificante, può essere inevitabile e giusto che una maggioranza anche esigua vada avanti.
Converrebbe allora che lo schieramento minoritario tenesse rigorosamente fede alle proprie preferenze e, quando viene il suo turno di governo, facesse tabula rasa del passato? In certe cose sì, in altre no, come ha spiegato Sergio Romano e come il dibattito politico presente sta mettendo in luce.
Se la democrazia è soprattutto un metodo per correggere gli errori, la revoca di scelte precedenti può essere doverosa, il motivo stesso per cui gli elettori si sono espressi col voto. Ma non è sempre così. Dopo essere stata compiuta e attuata, una scelta diviene un dato di fatto per tutti, anche per coloro che l’ hanno avversata.
Chi governa, governa il futuro, decide per un tempo più lungo del proprio mandato. Ogni forza politica democratica è erede dell’ opera dell’ avversario e il Paese nel suo complesso ha interesse a che essa dedichi il suo tempo non a disfare ma a fare. Blair ha assunto l’ eredità di Margaret Thatcher, Mitterrand quella di de Gaulle e Giscard, D’ Alema quella di De Gasperi.
Insomma, né la continuità né la discontinuità possono assurgere a criterio dominante per la conduzione di pubblici affari.
Formulare una regola tecnica per il ricorso all’ una o all’ altra è impossibile. Quello che si può pensare è un principio di equilibrio, la cui applicazione concreta è, e deve restare, affidata a una valutazione caso per caso. Il principio di equilibrio si potrebbe enunciare così: il buongoverno richiede che ogni forza politica riconosca un interesse superiore non solo al proprio interesse di parte, ma addirittura alla propria concezione dell’ interesse pubblico. E’ questo, si potrebbe dire, l’ elemento etico da cui la buona politica non può separarsi.
Di questo principio sono custodi ultimi quei corpi della società che, proprio per il fatto di non essere tenuti a una disciplina di parte politica, hanno la libertà di farsi guidare solo dalla ricerca di quell’ interesse superiore. Questi corpi sono la stampa, la classe dirigente, gli elettori e segnatamente, tra loro, chi coltiva la libertà di «far parte per se stesso», di formarsi un’ opinione propria e indipendente caso per caso, di non iscriversi a nessun club, di cambiare idea.