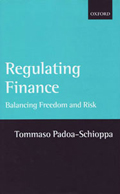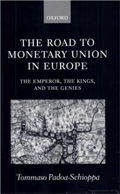Intervista a Padoa-Schioppa:
di Fabrizio Forquet
«L’ho visto lì a Pechino, gli ho parlato a lungo proprio nelle ore in cui voci tendenziose lo davano per scappato». Tommaso Padoa-Schioppa è diventato in questi giorni il testimone vivente, in Europa, della falsità della leggenda web che voleva il governatore della banca centrale cinese, Zhou Xiaochuan, in fuga negli Usa con la cassa. L’ex ministro dell’Economia oggi è presidente dei trustees della Fondazione Ifrs, che stabilisce gli standard contabili internazionali. Ed è in questa veste che è stato in Asia per una serie di incontri da cui è appena rientrato.
Che impressioni ne ha tratto? L’Asia continuerà a correre e potrà fare da traino alla ripresa mondiale?
La forte crescita che ha caratterizzato gli anni ante-crisi è ripresa nei paesi emergenti, mentre non lo è nei paesi avanzati. E il motivo è presto detto: sono due crescite profondamente diverse. Nei primi essa è un processo, spesso impetuoso, di uscita dalla povertà. È connessa al fatto che la gente si compra le scarpe, mentre prima andava a piedi nudi, si fa arrivare l’acqua corrente a casa, il telefono, compra il frigorifero…
Come l’Italia del dopoguerra.
Sì. E questa è una crescita che non si ferma facilmente, perché è una trasformazione sociale. Lo sviluppo dell’industria manifatturiera serve innanzitutto un mercato interno, che si va sviluppando. Negli anni 50 e 60 gli italiani fabbricavano automobili ed elettrodomestici perché milioni di persone se li compravano per la prima volta. Quando poi il mercato diventa di sostituzione tutto è più lento e più difficile.
E la crescita, se si ferma, fa fatica a rilanciarsi.
Nei paesi prosperi l’espansione economica è fondata sulla sostituzione di beni che già si posseggono, perciò è fragile. Chiunque può rinviare le scelte di acquisto. E, in più, è in questi paesi che si sono registrati gli squilibri finanziari principali, soprattutto con il forte indebitamento delle famiglie negli Stati Uniti.
Dopo l’ottimismo della tarda primavera, alcuni segnali indicano un rallentamento. Dobbiamo aspettarci una nuova flessione, il cosiddetto double dip?
Il rallentamento c’è. Se questo porterà a un double dip si vedrà. È importante capire che politica si fa nei paesi prosperi. Gli Stati Uniti puntano sullo stimolo della domanda, con strumenti fiscali e monetari. L’Europa guarda più all’equilibrio monetario e fiscale e non condivide l’idea che si possa
a qualunque costo ritornare alla crescita pre-crisi come massima priorità. È un modo molto diverso di vedere la realtà. E io mi aspetto che nei prossimi mesi le tensioni aumenteranno: gli americani premeranno sugli altri paesi avanzati perché stimolino la crescita, le divergenze di crescita e di politiche monetarie avranno riflesso sui cambi, le pressioni sulle banche centrali che non vogliono fare un’aggressiva politica espansiva aumenteranno.
Uno scenario preoccupante.
La mia sensazione è che l’alto grado di accordo internazionale che c’è stato nella fase più acuta della crisi adesso non ci sia più. Ed è ben possibile che le tensioni siano destinate a crescere e a diventare tensioni commerciali, politiche, finanziarie. Sono prospettive non particolarmente incoraggianti.
Ma secondo lei chi ha ragione? Meglio gli stimoli o il rigore?
Ritengo che l’Europa abbia una linea migliore di quella americana. Perché credo che si debba partire da un’idea chiara di quale sia una crescita sostenibile, abbandonando l’anelito a tornare alla crescita che ci ha portato alla crisi. Da questo punto di vista la visione europea è più equilibrata di quella americana. Sono convinto che ci sia un limite agli stimoli macroeconomici.
Non c’è il rischio di restare fermi, mentre il mondo intorno torna a correre?
Il rischio c’è, anche se non fa un’enorme differenza che ci sia un dato negativo per un trimestre o due. Di certo gli stimoli fiscali stanno esaurendo il loro effetto e le famiglie in America non sono disposte a consumare come prima, quando per farlo si indebitavano sugli incrementi di valore della casa: il crollo dei prezzi immobiliari è stata un’esperienza traumatica e non c’è nessuno stimolo che possa far superare quel trauma. È comprensibile e giusto che sia così. Pensare che la politica economica sia onnipotente di fronte a un fenomeno strutturale, e trattare il rallentamento come fosse un fatto ciclico, non coglie l’essenza di quel che è accaduto.
Dobbiamo rassegnarci alla bassa crescita?
La crescita in sé non dovrebbe essere un obiettivo assoluto, ma non va nemmeno demonizzata, come alcuni giovani fanno. Bisogna parlare di crescita sostenibile: quella pre-crisi non lo era perché poggiava su debiti crescenti e finanza avventurosa. Ora dobbiamo cercare un percorso diverso, che tenga conto anche della sostenibilità ambientale, dell’uso delle risorse naturali, delle diseguaglianze sociali. La politica economica deve senz’altro proporsi un tasso di occupazione elevato, ma non è detto che questo si riassuma in un tasso di crescita elevato. Pensare che drogare il Pil sia l’unico modo per tornare a creare posti di lavoro può essere sbagliato.
Per tornare a crescere certamente vanno riscritte le regole dei mercati finanziari, ma su questo punto si sono fatte molte discussioni e si sono prese poche decisioni.
Il comitato di Basilea ha fatto buoni progressi, ma non ha ancora scoperto pienamente il suo gioco. C’è stata una tendenza forte a privilegiare riforme nazionali nonostante il tentativo di coordinamento nel G-20. Le nuove regole negli Stati Uniti non sono state concordate con gli altri paesi. E l’Europa si è concentrata sugli hedge fund, sui compensi dei manager, sulle agenzie di rating: temi che non sono al centro della discussione negli Usa. Il rischio che dal processo di riforma esca un sistema più frammentato è forte.
Tra i rischi c’è anche quello che la riforma di Basilea possa restringere ulteriormente il credito alle imprese.
È presto per giudicare, perché i parametri vanno ancora calibrati. Le proposte del dicembre scorso erano giustamente preoccupanti, perché si passava da un eccesso di lassismo a un eccesso di rigore, poi le cose si sono attenuate. Aspettiamo di vedere dove ci si assesterà.
Da noi in Italia c’è chi rilancia i tagli fiscali. È una
ricetta possibile?
Quando uno fa proposte che invece di ridurre il deficit lo aumentano, mi piacerebbe che spiegasse bene come si fa a mantenere i conti a posto. Lo dico anche per l’esperienza che ho fatto al ministero dell’Economia: parlare di una riduzione generica dell’imposta non ha senso, si deve dire dove si recuperano i soldi che verranno a mancare e magari quali altre tasse vanno aumentate.
Sembra di sentire Tremonti.
Nel suo agire vedo una continuità con la politica del governo Prodi. La vedo e la condivido. Tremonti è stato sin dall’inizio consapevole del fatto che l’Italia non aveva margini di manovra. E questo è un fatto positivo.
I suoi ex colleghi di governo ancora imprecano: lei non mollava un centesimo.
Anni fa, i miei amici del Tesoro francese mi dicevano che il loro atteggiamento verso gli interlocutori era: «La risposta è no; ma, ricordami, qual era la domanda?». Non ci sono dieci modi per tenere a posto i conti.
Sui titoli pubblici europei in primavera è stata tempesta. Ora i mercati finanziari sembrano aver cambiato obiettivi, il rigore comincia a produrre i suoi effetti?
L’ondata di panico strisciante che c’è stata in primavera era un’assurdità. Se lei va a vedere la lista dei paesi che hanno fatto default negli ultimi 50 anni si accorge che è una lista esigua e che non c’è nessun paese con le caratteristiche di quelli europei. I mercati sono in uno stato di agitazione tale che non sono i fatti a determinare il nervosismo, ma è il nervosismo che inventa oggetti di cui alimentarsi. E l’ultimo oggetto è stato la preoccupazione per i debiti sovrani europei.
La Grecia, la Spagna… Non erano, e non sono, solo fantasmi.
Si è ecceduto. Ed era sbagliata anche l’idea che l’Unione europea fosse impotente, incapace di agire: è stata clamorosamente smentita dalle decisioni di maggio e di giugno. A maggio, con il piano sul fondo
speciale e sul pacchetto Grecia. A giugno, con l’avvio della fase di consolidamento dei conti pubblici. I paesi europei si sono mossi bene, compreso il nostro. Il paradosso è che i mercati sono passati subito dopo a preoccuparsi delle conseguenze negative sulla crescita che quell’aggiustamento di bilancio – fino a un’ora prima da loro stessi invocato – poteva avere. L’isteria è fatta di questa stoffa. Per fortuna adesso il clima sembra cambiato, forse chi opera sui mercati finanziari è andato in vacanza…
Le tensioni sui mercati torneranno o si può essere ottimisti?
Non credo che quello di primavera sia stato l’ultimo sussulto di questa crisi. Per le ragioni che dicevamo, vedo divergenze profonde. Non si uscirà dalla crisi con una crescita forzata e ci sarà ancora disoccupazione. Ci possono essere tensioni politiche, conflitti commerciali, disordine nei cambi. È un complesso di rischi tutt’altro che scongiurato. In questo clima ci sarà ancora spazio per l’isteria dei mercati. E ci potranno essere tensioni sociali. La questione sociale, nei nostri paesi, non è scomparsa: ha preso forme diverse da quelle di una volta, ma sta ritornando, strettamente connessa con l’internazionalizzazione dei mercati, come dimostra anche il caso Fiat.
Marchionne ha fatto vedere improvvisamente il re nudo: se non si adeguano le regole diventa difficile tenere certe produzioni in Italia.
Marchionne ragiona in una logica globalizzata e ha gettato un sasso nello stagno. È presto per dire quale sarà l’esito della vicenda. Di certo lo stato sociale, comprendendo in questo anche una tutela forte del lavoro, è una splendida caratteristica dell’economia europea. Non c’è alcuna altra parte del mondo che abbia realizzato un simile progresso, neppure tra i paesi industriali avanzati. Non credo che la globalizzazione ponga il dilemma se deindustrializzarsi o smantellare lo stato sociale. Penso che sia possibile evitare sia l’una che l’altra di queste due sciagure. E ci sono esempi in Europa che lo confermano: la Germania, i paesi nordici. Lì è rimasta una industria manifatturiera competitiva e c’è uno stato sociale anche più avanzato del nostro. E sono paesi dove il movimento sindacale è molto forte.
Anche l’Italia è uno dei paesi della Ue dove l’industria manifatturiera è rimasta importante. Ma non sempre tutto il sindacato dimostra la consapevolezza necessaria.
Una parte del sindacato ha difeso troppo a lungo uno stato di cose non più difendibile. E con questo ha anche rischiato di essere tagliato fuori dalla gestione del cambiamento necessario o addirittura di scomparire. L’ho constatato io stesso quando sono stato al governo: con l’Alitalia, con lo “scalone” pensionistico, con il contratto del pubblico impiego. Il rischio è che se il sindacato gioca la sua influenza su cose sbagliate vince la battaglia e perde la guerra. Così si
viene scavalcati ed emarginati dalla storia: i giovani non si iscrivono e il sindacato diviene una lobby di pensionati. Questo esito non
è auspicabile per nessuno. Ma che il sindacato scompaia o no dipende dal sindacato stesso.