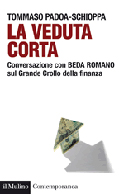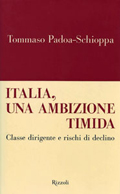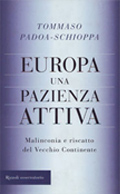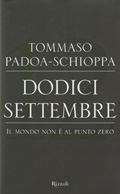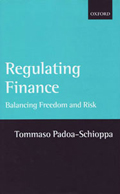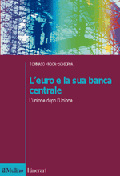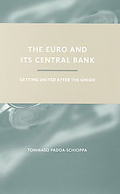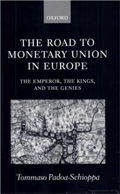Come dire “sì” in francese
Chirac e gli umori antieuropei
Tra due mesi esatti la Francia del no e quella del sì (sì all’ Europa, ma anche a un’ incisiva presenza nel mondo) s’ affronteranno nuovamente: è una tenzone che da oltre mezzo secolo la divide e che segna il destino europeo. Se il no alla Costituzione europea sembra ora in grado di prevalere è perché il Paese non ha preso sufficiente coscienza di un fatto fondamentale: il dispositivo che per decenni fu leva della sua leadership – il potere di veto – non l’ avvantaggia ormai più, la danneggia. Bocciando la Costituzione, la Francia direbbe un no non tanto all’ Europa quanto a se stessa, al ruolo guida che ha esercitato per quarant’ anni e che dal 1989-91 sembra avere smarrito.
Il dispositivo aveva funzionato a meraviglia per circa trent’ anni. Nell’ Europa a sei, cinque Paesi avevano la disponibilità illimitata di formare una vera unione politica ed erano i francesi, col loro veto, a dosare il quantum. Potevano avere tanta unione quanta volevano: non di meno, perché gli altri ne volevano comunque di più; non di più, grazie al veto. Il meccanismo era completato – sul piano economico e finanziario – dal ruolo di ufficiale pagatore (Zahlmeister) cui era condannata una Germania ancora prospera e penitente.
L’ intero meccanismo si logorò gradualmente con l’ ingresso della Gran Bretagna e l’ uso del veto da parte di altri Paesi. Infine, si bloccò del tutto con la riunificazione tedesca, la caduta dell’ impero sovietico, il venire meno di un contrappeso all’ egemonia americana.
A Parigi non si intuì che per mantenere la guida europea occorreva trasformarsi da monopolisti del veto in organizzatori di maggioranze europee: un ruolo che la Germania era ancora riluttante a esercitare e nel quale la Gran Bretagna non poteva fare concorrenza, perché non disposta al rischio di trovarsi talora in minoranza. Così, dopo il 1989-91, la Francia perse, una dopo l’ altra, ogni occasione di aggiornare la sua politica europea e mondiale.
La Gran Bretagna, essa, disponeva di una leva alternativa che alla Francia mancava: il patto d’ acciaio con gli Usa, con la speranza (spesso vana) di uno speciale dividendo della loro egemonia. Aveva, come Paese insulare, un minor bisogno di Europa e possedeva un suo, seppur diverso, dispositivo per avere «tanta unione quanta ne voleva»: la pratica di star fuori dagli accordi sgraditi (l’ opt out: euro, Schengen).
Tutto ciò non è stato capito a fondo dalla classe intellettuale e politica di una Francia colta di sorpresa dal 1989-91 e ancora illusa, in maggioranza, di essere uscita indenne dalla Seconda guerra mondiale, di poter davvero stare fuori dalla Nato, di poter guidare la politica europea senza alcuna limitazione della propria sovranità. La vicenda irachena è stata solo la più recente prova della grande illusione.
Pochi sembrano oggi riconoscere, a Parigi, che i suoi momenti di grande politica la Francia del dopoguerra li ha avuti nel segno del realismo, non dell’ illusione; li ha avuti quando ha dato, non quando ha preso; quando ha detto sì, non quando ha detto no. Grandi momenti sono stati l’ offerta del suo acciaio alla Germania appena sconfitta, la firma (governativa) del trattato Ced della difesa comune, di quello di Roma, l’ indipendenza algerina; non il no (parlamentare) alla stessa Ced, alla Nato, al principio maggioritario in Europa.
Se una possibilità di leadership francese in Europa ancora esiste, essa sta vivendo la sua ultima breve stagione. E se vi è un modo per coglierla esso consiste, per la Francia, nel dare qualcosa di suo: la ratifica della Costituzione, il seggio all’ Onu o al Fondo monetario, la copertura nucleare. Nella politica, come nella finanza, le opzioni scadono. Forse, per la Francia la scadenza è il 27 maggio prossimo.