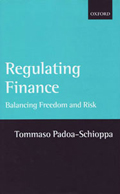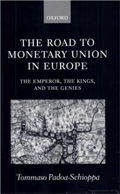Via le rendite o l’Italia torna povera
Il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa: «Dai piloti ai giudici, troppi privilegi. Va ritrovata l’ambizione nazionale»
Caro Direttore,
tra le cose da cui mi sono staccato a malincuore nel prestare giuramento come ministro della Repubblica vi è il privilegio di un regolare colloquio con quelli che erano divenuti i miei lettori: alcune centinaia di migliaia di persone di cui sentivo, pur non conoscendole individualmente, la viva partecipazione alla vita civile dell’Italia, il desiderio di capire la res publica, la volontà di farsi un proprio giudizio su grandi questioni del mondo di oggi. Oggi scrivo come colui che cerca di rendere conto dei motivi della propria azione, non di offrire un commento.
Coi miei vecchi lettori vorrei condividere una riflessione sulla questione che più mi occupa: come riportare l’Italia dalla stagnazione alla crescita?
In sintesi, risponderei così: si ritornerà alla crescita solo se all’ansia della rincorsa, che ci ha sospinto per anni, subentrerà, quale spirito animatore, una ambizione nazionale. Desiderio di eccellere come Paese, fiducia nelle sue forze, sguardo lungo.
Sono passate due generazioni dacché l’Italia usciva — sconfitta, distrutta e screditata agli occhi del mondo — dalla guerra e dalla dittatura, due sciagure di cui responsabili ultimi furono gli italiani stessi, soprattutto i più colti e benestanti. Soffrivamo di una povertà che oggi osserviamo solo in Africa o in Asia: denutrizione, analfabetismo, diffusione di malattie mortali, case senza elettricità né acqua corrente, mancanza di lavoro e di elementare tutela nello stesso. Per decine di migliaia di toscani, abruzzesi, veneti, lucani la sola speranza era emigrare in Belgio, Francia, Germania, Svizzera o verso continenti lontani.
Nello spazio di due sole generazioni, gli italiani hanno realizzato — per merito loro e di chi li ha governati — una delle più profonde trasformazioni della loro storia: nel tenore di vita, nelle abitudini, nei rapporti personali e familiari, nella vita sociale, nelle istituzioni.
La trasformazione è andata di pari passo con la crescita economica, che per cinque decenni è stata superiore a quella dell’Europa in cui ci integravamo. In parte la trasformazione ha coinciso
con la crescita stessa: scarpe ai piedi, casa, elettrodomestici, automobile, figli alle scuole superiori e all’università, vacanze. In parte essa è stata consentita dalla crescita: pensioni, servizio sanitario universale, statuto dei lavoratori.
Parlo di crescita: un continuo aumento della produzione di beni e servizi, che permane attraverso le pause e le riprese osservabili nelle economie che crescono come in quelle che declinano.
L’economia non ha ancora risposto alla domanda che l’ha fatta nascere come scienza: che cosa determina la crescita? La risposta meccanica si limita a poco più di una tautologia: alla lunga — dice — la crescita è azionata da due motori, le forze di lavoro e la produttività. Ma la risposta non meccanica, che guarda oltre la macchina produttiva, è più profonda e non si racchiude in una formula algebrica: la crescita è un fatto della società, è voglia di costruire cose nuove, di guardare lontano, è fiducia nelle proprie forze, ambizione. Gli economisti parlano di «spiriti animali» ( animal spirits); ma Ulisse e Dante, al contrario, vi vedono l’essenza migliore dell’umano: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza».
Lo spirito che soffiò nei primi decenni del dopoguerra e sospinse la crescita lo potremmo chiamare ansia della rincorsa. Dai vertici rinascimentali del benessere, della raffinatezza, della produzione artistica e scientifica, dell’eccellenza nel mestiere delle armi e della politica l’Italia era discesa nella mortificazione di offrirsi come campo di battaglia e terra di conquista per le dinastie e gli Stati potenti («Francia, Spagna purché se magna»), terra di cuochi e di cantanti da esportazione. Dopo secoli di declino, il secondo dopoguerra è stato la breve stagione in cui abbiamo riagganciato l’Europa prospera.
Da circa dieci anni l’ansia della rincorsa non basta più quale propulsore della società italiana. Entrambi i motori della crescita hanno perso potenza. Poche le nascite, poche le persone che partecipano alle forze di lavoro; l’immigrazione di mano d’opera non qualificata non basta a tenere su di giri il primo motore. Pochi investimenti, poca ricerca in sempre meno numerose grandi imprese, poche invenzioni, pochi brevetti italiani, poca flessibilità del lavoro nell’impiego pubblico e in quello privato: il secondo motore si è quasi spento. Soprattutto, poca fiducia, poca voglia di eccellere, paura di cambiare, rifiuto del rischio.
Abbiamo rallentato la capacità di produrre e troppi si aggrappano alla rendita. La differenza stessa tra produzione e rendita talvolta ci sfugge. È rendita quella del giovane che si definisce imprenditore, mentre sta consumando l’avviamento dell’impresa fondata dal padre o dal nonno. O quella del titolare di cattedra che da anni non fa ricerca, non pubblica su serie riviste scientifiche, e non c’è mai per gli studenti. O quella del contratto di lavoro inflessibile, sempre più in contraddizione con la concorrenza mondiale e col cambiamento tecnologico. O quella dell’impiego pubblico dove l’impiegato non può essere trasferito ad altro luogo di residenza, né a diversa mansione, e neppure a diverso ufficio, mentre spesso nessuno controlla se va o no al lavoro. Due mesi l’anno di vacanza per i magistrati; due giorni la settimana di servizio per i piloti d’aereo; tre-quattro ore d’insegnamento la settimana (per pochi mesi l’anno) per l’accademico.
Ci siamo perfino abituati a sprecare la rendita: pigri studi in campi che non danno né vera cultura né prospettive di lavoro; largo consumo di beni superflui; prolungate degenze in ospedale in attesa di analisi che non richiedono ricovero; consumo dell’ambiente naturale.
Nelle imprese, nelle scuole, nella pubblica amministrazione, nei laboratori di ricerca e nei tribunali, nell’università vi è un’Italia della produzione, del rischio, dell’eccellenza, che non si rassegna. La ripresa in corso è anche suo merito. Ma non illudiamoci: se non avviene un mutamento profondo, se questo altro Paese non prende il sopravvento, l’Italia ridiventa un Paese povero. Povero al modo europeo del ventunesimo secolo, certo. Non più la pellagra e la malaria, non più famiglie di otto persone che dormono in una sola stanza e hanno il bagno in cortile, ma nuove forme di analfabetismo e di desolazione, degrado dell’ambiente, trascuratezza del costume. Quasi nessuno sa la lingua del mondo (l’inglese) proprio come quasi nessuno sapeva l’italiano quattro o cinque generazioni fa. Ignoranza del computer e della matematica. Incapacità di scrivere in italiano senza errori. Povertà di beni collettivi, di trasporti che funzionano, di servizi pubblici elementari, di sostegni per chi perde il lavoro, di difesa del suolo e del paesaggio, incapacità perfino di liberarsi dei rifiuti. Soprattutto, povertà di prospettive, di fiducia, di stima di sé.
Invece è possibile che si rafforzi e prevalga all’interno stesso del Paese la spinta di chi vuole perseguire l’eccellenza,superare i migliori, fare dell’Italia un Paese attraente per scienziati, imprenditori, ricercatori di talento, artisti. Nel tessuto sociale vi è questa aspirazione, la si avverte ogni giorno. L’ambizione, il desiderio di una meta alta, la disponibilità al sacrificio sono presenti. Dipende da chi governa e insieme dalla classe dirigente animare e valorizzare queste forze, offrire un sostituto all’incentivo esterno che ci ha spinti per anni (le regole di Bruxelles, la paura di star fuori dall’euro, e via dicendo).
Chi governa deve essere oggi guidato da una ambizione sul futuro del Paese anche superiore a quella che gli stessi italiani sembrano in genere manifestare; deve allungare lo sguardo oltre l’orizzonte nel quale il quotidiano dibattito sembra volersi rinchiudere. Certo, non può dimenticare che in democrazia il sostegno dell’elettore è condizione per governare legittimamente; ma nemmeno deve dimenticare che ogni serio cambiamento — e di questo l’Italia oggi ha urgente bisogno — implica decisioni impopolari. Guai a identificare la legittimazione col responso quotidiano dei sondaggi. I sondaggi hanno più a che fare con la psicologia e le carenze affettive che con le istituzioni e la democrazia.
Chi nella società — in virtù della propria posizione o anche solo della propria personalità — ha influenza sui comportamenti e i giudizi degli altri, ed è perciò parte della classe dirigente, deve sapere che di fatto è anch’egli parte del governo del Paese; e che dipende anche dal suo giudizio che l’opinione pubblica distingua l’essenziale dal secondario, l’effimero dal duraturo, che l’ambizione di un Paese migliore divenga desiderio e comportamento diffusi.